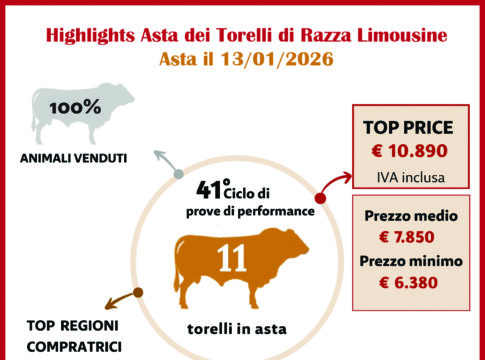Navigando in internet si trovano varie definizioni, più o meno simili, del concetto di filiera. Wikipedia la descrive come l’insieme articolato (anche detto ‘rete’ o ‘sistema’) che comprende le principali attività (e i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito. Il termine è stato usato per la prima volta negli anni Sessanta dall’agronomo francese Louis Malassis, che ha definito la filiera come “l’itinerario seguito da un prodotto all’interno del sistema agroalimentare”, o in maniera più precisa come l’insieme dei passaggi di elaborazione del prodotto fino al consumatore finale.
Nel 2018 il termine è molto usato, ovvero “va di moda”. Ma rimane ancora una definizione per descrivere i passaggi del prodotto e non certo un “sistema” o una “rete d’imprese”, poiché ogni anello della cosiddetta filiera fa storia a sè e difende il proprio territorio economico, per trarre il maggior profitto, a prescindere, invocando le leggi di mercato. Ovviamente ognuno fa la sua parte e non si può certo rimproverare gli anelli più forti di dominanza su quello più debole, poiché il mercato premia chi ci sa fare e bastona tutti gli altri.
In Italia la filiera zootecnica possiamo rappresentarla idealmente come una grande piramide dove in cima sta la distribuzione, nel mezzo l’industria di trasformazione e sotto la base, che tiene su tutto il resto, rappresentata dalla produzione.
I flussi sono noti: il prodotto va verso l’alto, il prezzo verso il basso. L’allevatore produce un buon bovino che vende al macellatore, che lo trasforma in carne, che finisce sui banchi della distribuzione. Il prezzo lo decide la distribuzione, che lo impone al macellatore, che a sua volta lo impone all’allevatore.
Il resto del mondo non va così: l’imprenditore produce un bene, calcola il costo di produzione di quel bene, stabilisce un prezzo per avere un utile e lo vende a chi poi lo distribuirà (intermediari compresi) sicuro di aver guadagnato il necessario per tenere in vita l’impresa ed investire per migliorarla.
Tutto questo è una premessa necessaria per discutere concretamente su come deve evolvere la filiera carne bovina in Italia.
L’utopia
Ci sono due strade parallele da percorrere: una riguarda la produzione, la seconda riguarda la commercializzazione.
Parliamo di produzione. Nel 2017 gli allevatori di bovini da carne italiani hanno importato dall’estero 919.710 ristalli da ingrassare (le vacche nutrici, in Italia, le abbiamo mangiate quasi tutte nel dopoguerra e mai più rimpiazzate). Considerando che un giovane bovino (circa 300 kg le femmine e circa 400 kg i maschi) costa mediamente circa 1.100 euro, nel 2017 abbiamo portato all’estero (principalmente in Francia) la bella cifra di oltre un miliardo di euro per acquistarli!
Quante vacche nutrici abbiamo in Italia? Circa 380mila, tra Piemontesi (il numero maggiore), Chianine, Marchigiane, Romagnole, Podoliche ed incroci vari). Quante ne ha la Francia? Oltre 4,3 milioni. Quanto costa una buona vacca nutrice? Circa 2mila euro. Abbiamo 600 milioni di euro per ripopolare l’Italia con almeno 300mila vacche nutrici ed ottenere circa 300mila vitellini all’anno?
Gli allevatori non li hanno. E considerato il tempo e la burocrazia assurda che stanno ancora ruotando attorno ai 25 milioni promessi al settore latte per la “crisi post quote latte”, anche solo pensarlo è pura utopia.
L’alternativa
Che alternative abbiamo? È presto detto: un’alleanza tra allevatori di bovini da carne e allevatori di vacche da latte per iniziare un percorso virtuoso di riduzione della dipendenza dall’estero, creare una produzione 100% italiana e lasciare un po’ di euro nelle tasche degli allevatori italiani. Nelle tasche sia degli allevatori di bovine da latte sia di quelli di bovini da carne.
Come procedere? Abbiamo in Italia circa 1.850.000 vacche da latte, lavoriamo tutti assieme per convincere gli allevatori ad usare il seme sessato per la rimonta interna, per liberare un po’ di uteri da dedicare all’inseminazione con seme di toro da carne e far nascere dei vitelli da avviare allo svezzamento e poi all’ingrasso.
Utopia? No di certo, se dividiamo per 2 il numero delle vacche da latte che potrebbero essere disponibili per questo progetto, ne abbiamo 925mila. Mettiamo che questo numero sia irraggiungibile e lo dividiamo ancora per 2, il numero di vacche rimaste diventa 462.500.
 Poter disporre di circa 400mila uteri per far nascere vitellini incroci da carne italiani, da avviare all’ingrasso, significherebbe ridurre la dipendenza dall’estero, tenere in Italia circa 440 milioni di euro e valorizzare i nuovi nati con una media di 400 euro cadauno, mettendo in tasca agli allevatori di vacche da latte circa 160 milioni di euro. Qualora questo succedesse e funzionasse non sarebbe poi difficile aumentare ulteriormente gli allevamenti di vacche da latte disponibili.
Poter disporre di circa 400mila uteri per far nascere vitellini incroci da carne italiani, da avviare all’ingrasso, significherebbe ridurre la dipendenza dall’estero, tenere in Italia circa 440 milioni di euro e valorizzare i nuovi nati con una media di 400 euro cadauno, mettendo in tasca agli allevatori di vacche da latte circa 160 milioni di euro. Qualora questo succedesse e funzionasse non sarebbe poi difficile aumentare ulteriormente gli allevamenti di vacche da latte disponibili.
La commercializzazione
E l’alleanza di cui sopra? Da una parte c’è l’Aia, Associazione italiana allevatori, che può contare su una capillare diffusione in tutte le regioni italiane, che può agire con l’assistenza tecnica, la certificazione e la raccolta dei vitellini nelle aziende di vacche da latte. Dall’altra c’è il Consorzio Italia Zootecnica, in procinto di diventare la prima grande Aop in Italia, che può organizzare contratti commerciali tra allevatori e con il resto della filiera.
E qui parte l’altra strada parallela: quella della commercializzazione.
Il marchio per rendere riconoscibile facilmente la carne prodotta in Italia c’è ed è stato registrato dal Consorzio Sigillo Italiano (l’etichettatura obbligatoria o l’indicazione dell’origine non bastano). Il ministero delle Politiche agricole ha fatto la sua parte riconoscendo i disciplinari di produzione del “Vitellone e/o Scottona ai cereali”, del “Fassone di Razza Piemontese”, del “Bovino Podolico al Pascolo” e “l’Uovo+ Qualità ai cereali”.
Il denaro privato per promuovere e valorizzare la carne prodotta in Italia (occorrono milioni di euro) può essere recuperato portando a riconoscimento statale l’Interprofessione della carne bovina. La quale, guarda caso, può e dovrebbe riunire l’intera filiera, produzione, macellazione, distribuzione, alla pari e non come una “piramide”.
Le altre parole d’ordine sono il calcolo certificato del costo di produzione dei bovini a marchio, il “mandato a vendere”, l’aggregazione del prodotto nelle organizzazioni produttori, l’informazione al consumatore, la pubblicità. Ovvero, l’attuazione del Piano carni bovine nazionale, che passo dopo passo sta prendendo forma.