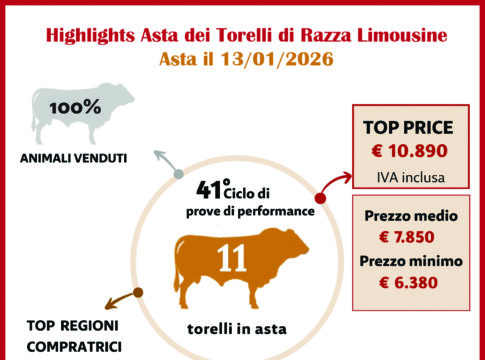“Ho appena realizzato che gli animali sono una tecnologia preistorica, che usare animali per produrre cibo è la tecnologia più distruttiva in uso sulla Terra ad oggi. La soluzione è usare una tecnologia migliore” (Patrick Brown, ceo di Impossible Foods).
Dietro queste parole, frutto di una triste affermazione di Patrick Brown, ceo di Impossible Foods, azienda leader nella produzione di “alternative” alla carne, nonché ideatore dell’Impossible Burger, ora a pieno titolo “hamburger” inserito nel menù di diverse catene di fast food prettamente “carnivore”, si nascondono due delle più grandi sfide con cui la zootecnia moderna deve, e sempre più spesso dovrà, confrontarsi: da una parte l’effettivo problema “ambientale” e dall’altra la guerra ad alcuni miti, le cosiddette fake news, che vogliono l’allevamento come il principale male del pianeta Terra.
Zootecnia sotto attacco
“È evidente come gli allevamenti intensivi siano la causa di pesanti ricadute sull’ambiente” tuona GreenPeace “che poi vanno ad influire anche sulla salute umana”, con anche altri slogan ed immagini crudeli di grande impatto sull’opinione pubblica, arrivando persino a chiedere di tagliare i fondi pubblici per l’agricoltura (n.d.r i fondi Pac) riservati, a loro detta, “alle aziende più inquinanti della Terra” (2019).
L’allevamento non va bene e va osteggiato. E non solo, vanno criticate, condannate e penalizzate tutte quelle persone che ancora mangiano carne, come se ci si trovasse già nella realtà virtuale prevista nel docu-film attivista “The Carnage” (2017) in cui, oltre a prospettarsi per il 2067 una società interamente vegana, chi ancora consuma prodotti animali viene trattato alla stregua di un alcolista e costretto a terapie psichiatriche ed alla pubblica gogna.
Ne è la riprova la proposta assurda, mossa al Parlamento Europeo il 5 febbraio 2020 proprio da queste ultime associazioni ambientaliste, di istituire una tassa europea sulla carne, per ripagare il prezzo ambientale che la sua produzione comporta. Non si parla di noccioline ma di un rincaro del 25% che penalizzerebbe pertanto la spesa di tutti i giorni del consumatore medio.
Ma l’avversione di queste associazioni animaliste ed “ambientaliste” per la zootecnia, specie se intensiva, non è cosa nuova, si è solo spostato il campo d’azione: dalla questione “benessere animale” agli aspetti ambientali. L’appeal di questi slogan è grande. L’opinione pubblica infatti è, sotto alcuni punti di vista, volubile e influenzabile.
Ne è una testimonianza la forte crescita che il vegetarianismo e veganismo stanno dimostrando in questi ultimi anni. Prendendo ad esempio gli Stati Uniti, la nazione carnivora per eccellenza, se nel 2014 i vegani rappresentavano meno dell’1% della popolazione totale, in soli 3 anni questo numero è lievitato, fino a raggiungere la quota del 6%. E in Europa la situazione non è certamente migliore. Nella maggior parte dei paesi il numero di vegani e vegetariani è più che raddoppiato.
A risentirne sono anche il mercato e l’economia del comparto zootecnico. Le vendite di prodotti sostitutivi hanno infatti raggiunto un aumento del 31%.
Quel che è peggio ed avvilente è che anche programmi televisivi e testate giornalistiche di portata nazionale, che si prefiggono di fare un’informazione seria e addirittura “scientifica”, abbiano rincominciato, e proprio in questo periodo di dramma umanitario ed economico mondiale, una vera campagna denigratoria nei confronti della zootecnia, con affermazioni faziose sul potenziale impatto sull’ambiente e persino attribuendo al settore una responsabilità nella diffusione del Coronavirus. Il tutto sempre basandosi su dati palesemente errati, non scientifici e che di vero hanno solo la non veridicità.
Un dato di fatto: il clima sta cambiando
Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. I ghiacciai si stanno ritirando a grande velocità, complici le impensabili temperature, raggiunte ormai anche ai poli (19°C!). La Mongolia è colpita da un’ondata di siccità mai vista, e sulla Thailandia imperversano alluvioni potenti. In Australia incendi devastanti hanno distrutto gran parte del territorio, con danni enormi sull’ecosistema e sulle attività umane.
Per avere un dato certo e toccabile con mano, la Nasa ha confrontato, mensilmente, la temperatura della superficie terrestre dal 1880 ad oggi. I risultati sono sicuramente impressionanti: è stato rilevato un aumento di +2°C! (Nasa, Giss Surface Temperature Analysis (v4) (2020)).
Che il clima e l’ecosistema terrestre stiano cambiando non è più quindi una fantasia di pochi. È diventato piuttosto un dato di fatto, una realtà.
Certo, nella storia geologica della Terra sono avvenuti diversi mutamenti climatici. L’alternanza di glaciazioni e desertificazioni ne è un esempio. Quello che però rende “diversi” gli episodi attuali è il fattore velocità. In natura ogni cambiamento è lento, su una scala di milioni di anni, permettendo agli organismi viventi di adattarsi. I cambiamenti climatici attuali sono invece drastici e veloci, segno indiscusso di una violenta influenza antropica.
A corroborare questa certezza sono anche i dati relativi al momento di inizio di questa impennata nei mutamenti climatici. Tutto ha inizio infatti con l’industrializzazione (anni ‘50 circa), momento in cui il consumo di combustibili fossili è aumentato esponenzialmente: a conferma di ciò, l’analisi dei costituenti degli “ice-cores”, ovvero dei cilindri di ghiaccio stratificato usati per studi sull’evoluzione della composizione dell’atmosfera terrestre. Per millenni la concentrazione di CO2 è stata al di sotto della soglia di 300 ppm ma, dal 1950 circa, si è assistito ad un aumento esponenziale.
È quindi palese che l’uomo, con tutte le sue molteplici attività, sia integralmente coinvolto nella genesi del cambiamento climatico e come ad oggi sia chiaramente necessario attuare alcuni sostanziali cambiamenti in una direzione eco-friendly. Ma le azioni devono comunque essere intraprese sulla base di studi e dati scientifici, considerando tutti i diversi settori produttivi e non semplicemente rovesciando tutte le colpe su un unico capro espiatorio: la zootecnia!
Il valore del prodotto finale
È il caso di fare un po’ di chiarezza e di separare i fatti, la realtà, dai miti e dalle fake news, usando invece la correttezza ed il rigore scientifico. Le sfumature da valutare, nel comparare le diverse attività umane clima-alteranti, sono molte, primo fra tutti il “valore” del prodotto finale.
Le produzioni zootecniche infatti, oltre a garantire nutrienti di elevatissimo valore biologico, difficilmente rimpiazzabili da prodotti vegetali, sono anche una fonte di reddito essenziale per un vasto numero di persone. Non va dimenticato che il concetto di “sostenibilità” è in realtà ben più ampio dei soli aspetti ambientali e abbraccia anche l’economia ed il sociale, inteso come sviluppo di una comunità e di una di una società e anche come salvaguardia della sua salute.
Allevamento e ambiente l’inizio della diatriba
“Il settore zootecnico è uno dei principali attori, responsabile del 18% delle emissioni di gas serra misurate in CO2 equivalenti. Questa è una quota maggiore rispetto ai trasporti” Fao, Livestock’s Long Shadow (2006).
È da questa affermazione, da quando questa frase e questi dati sono diventati di dominio pubblico, che è iniziato il panico globale nei confronti degli allevamenti e del loro impatto sull’ambiente.
Si tratta infatti di un’affermazione forte (n.d.r. il 18% non è riferito all’intera attività agroalimentare bensì solo alla componente zootecnica), pubblicata in un documento ufficiale, da un ente governativo delle Nazioni Unite, derivante da studi scientifici accreditati ed attendibili. È quasi naturale che la gente, i consumatori ed anche parte del mondo scientifico abbia creduto, sottoscritto e divulgato questa teoria.
Tuttavia è un’affermazione errata. Lo dimostrano le critiche mosse dal professor Frank Mitloehner, Air quality specialist presso l’Università della California UC Davis, (American Chemical Society (Acs) meeting in San Francisco, 2010). Non è tanto il dato percentuale, 18%, di per sé calcolato quasi in maniera fin troppo oculata, ad essere errato, quanto il sistema di comparazione messo in atto.
Non c‘è stata infatti univocità nei sistemi di calcolo delle emissioni di allevamenti e trasporti. Sono stati invece usati due pesi e due misure. Se per la zootecnia è stata usata, correttamente peraltro, la metodologia Lca (Life Cycle Assessment), che in maniera puntigliosa esamina tutti gli aspetti che concernono l’allevamento, a partire dalla coltivazione delle materie prime, considerando addirittura la produzione di fertilizzanti, fino agli impatti derivanti dal consumo finale del prodotto, la stessa accuratezza non è stata usata per il settore dei trasporti.
La quantificazione ha riguardato solo le emissioni effettive derivanti dal movimento dei mezzi stessi. Non sono stati inseriti dei tasselli importantissimi ed altamente impattanti quali l’estrazione dei combustibili fossili e la produzione stessa dei mezzi di trasporto. Sebbene queste affermazioni siano state riconosciute, accettate e corrette dalla Fao stessa (Steinfield et al., 2010), hanno comunque lasciato un segno indelebile.
La realtà tuttavia è profondamente diversa.
“Possiamo, mangiando ciò che desideriamo, ridurre il nostro impatto sul clima?”
“Ciò che noi mangiamo, è importante quando ci si riferisce ai gas serra, quando ci si riferisce all’impatto ambientale in generale? Importa, ma in misura molto minore” (Frank Mitloehner, Air quality specialis, Università della California UC Davis).
In altre parole, la decisione di convertire totalmente le proprie abitudini verso stili di vita vegani e vegetariani, consentirebbe veramente di salvare il pianeta?
Teoricamente un impatto sarebbe plausibile. Bisognerebbe valutarne però l’entità, comparandone gli eventuali risvolti. In una serie di interessanti video divulgativi (“Cows and climate”) del professor Frank Mitloehner, il passaggio di un individuo da una dieta standard statunitense ad una vegetariana/vegana porterebbe a ridurre le emissioni di gas serra equivalenti ad un singolo volo da New York all’Europa (pari a 1.6 ton).
Se tutti gli americani diventassero improvvisamente vegetariani/vegani la carbon footprint degli Stati Uniti si ridurrebbe del 2.6%. Una percentuale davvero modesta. Questo considerando, una dieta americana tipica, dove la carne sicuramente gioca un ruolo importante.
Il dato sarebbe ancora più irrilevante se ad essere considerata fosse una dieta standard di tipo mediterraneo, in cui la carne è presente in quota meno preponderante.
Questo senza considerare che una conversione alimentare verso il vegetariano/vegano imporrebbe un aumento della produzione agricola che non sembra essere sostenibile, considerando la disponibilità di terra attuale e soprattutto le diverse tipologie di terreni, differenti per composizione del suolo, caratteristiche irrigue etc. (Petersen et al., 2016). In presenza di regimi totalmente vegetariani/vegani, la carrying capacity, ovvero il numero di persone alimentate per unità di terreno, sarebbe significativamente inferiore.
Devono infatti essere esclusi dal computo delle terre produttive tutti i suoli che, per caratteristiche intrinseche, non sono idonei alle produzioni di alimenti vegetali per l’uomo (cereali e ortaggi), ma che invece sono perfettamente utilizzabili per la produzione di talune materie prime per mangimi e/o per la produzione di foraggi ed il pascolamento.
Questi terreni, ad oggi largamente usati per la produzione di alimenti zootecnici, in un mondo vegetariano/vegano sarebbero sostanzialmente inutilizzati, perdendo un grosso potenziale produttivo.
Sempre considerando la realtà statunitense, le statistiche confermano il modesto contributo della zootecnia sulle emissioni di gas serra (20% vs 80% relativo all’utilizzo di combustibili fossili).
Le medie globali
Inoltre, benché sia metodologicamente scorretto fare medie globali per parlare di impatto climatico, data l’elevata variabilità delle emissioni degli allevamenti nei diversi paesi, dovuta ad una molteplicità di fattori (clima, prassi di allevamento, genetica degli animali usati, livello tecnologico etc.), le medie globali presentano numeri favorevoli per il comparto.
Il settore agro-zootecnico, e, attenzione, in questo termine sono comprese anche tutte le coltivazioni vegetali per il consumo umano (ortaggi, cereali, frutta etc.), contribuisce per il 20% alle emissioni complessive di gas ad effetto serra, espressi in CO2 equivalenti, (unità di misura di riferimento in cui vengono espresse le emissioni di tutti i principali gas serra: metano, anidride carbonica, ossidi di azoto etc) (Fao, 2017).
All’interno di questo 20%, la zootecnia impatta per il 10%, o 14.5% se si considerano anche le emissioni derivanti dai cambiamenti di utilizzo del suolo.
Da notare che nel 1990 l’incidenza era rispettivamente del 17% e del 25%.
Anche i dati italiani confermano il basso impatto del comparto, addirittura inferiore alle medie mondiali. Le produzioni agricole rappresentano il 7,1% delle emissioni italiane di gas serra ed il contributo della zootecnia è del 5.6% (report Ispra del 2020). Dal 1990 al 2018 le emissioni dei gas serra del settore agricolo sono scese dal 13% (Ispra 2020).
Effetto Coronavirus
Anche la situazione attuale, dovuta all’effetto “Coronavirus”, evidenzia chiaramente e incontrovertibilmente le reali responsabilità. La forte limitazione dei trasporti ha infatti determinato una drastica riduzione degli inquinanti in atmosfera.
A Milano, nelle ultime settimane, la concentrazione di PM10 nell’aria non ha mai superato la quota limite di 50 mg/m3, a fronte di valori medi standard di 75-95 mg/m3. Lo stesso vale anche per le aree degli altri focolai lombardi di Coronavirus, Codogno, Bergamo e Brescia, che registrano valori straordinari di 20, 14 e 18 mg/m3 di PM10, pur essendo aree a forte attività zootecnica (dati Arpa Lombardia).
Si stima che in generale le emissioni di questo trimestre del 2020 saranno del 5-7% inferiori rispetto al medesimo periodo del 2019 (Ispra 2020). Tali risultati scaturiscono solo ed esclusivamente dalla netta riduzione dei trasporti e delle attività industriali non essenziali, e non certamente delle attività zootecniche che hanno invece continuato la normale attività produttiva.
Il contributo della zootecnia all’inquinamento da PM10 ed anche da PM2.5 è infatti infinitesimale rispetto ad altri comparti. L’Ispra riporta un contributo del comparto agro-zootecnico del 11.8% per il PM10 e del 3.2% per il PM2.5, con un calo del 10% rispetto al 1990.
Ad essersi ridotta è anche la produzione di ammoniaca degli allevamenti, il principale indagato nella costituzione del PM2.5. Dal 1990 le emissioni di ammoniaca del settore sono calate di oltre il 23%, dato che rende il comparto sempre più vicino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato per il 2030 dall’Unione Europea (Ispra 2020).
Altri settori invece sono assai meno virtuosi. Per esempio, il settore dei riscaldamenti infatti ha un impatto ben più alto sulla produzione di PM2.5: si parla del 54%, con un aumento rispetto agli anni 2000 del 153% (Ispra 2019).
Un impatto ancora da rivedere e riconsiderare
Questi dati vanno però ulteriormente analizzati e in un’ottica più ampia. Ci sono diversi fattori che possono spostare l’ago della bilancia ancora più a favore degli allevamenti.
In primo luogo va considerato che, contrariamente agli altri settori inquinanti (trasporti, energia ed industria) la zootecnia è l’unico comparto che, oltre ad emettere gas serra, ha anche una controparte che contribuisce ai processi di “assorbimento e smaltimento” di tali sostanze.
Nelle piante coltivate ad uso zootecnico infatti, avviene una reazione fondamentale, il ciclo di Calvin-Benson, per cui, durante la fase terminale della fotosintesi clorofilliana, molecole di anidride carbonica vengono prelevate dall’atmosfera e “fissate” in un composto organico, uno zucchero. Oltre quindi a ridurre la carica atmosferica di questo inquinante, lo trasformano addirittura in un nutriente, che poi verrà a sua volta usato dagli animali e convertito in alimento per l’uomo. Si tratta di un ciclo naturale.
Al contrario, i processi di estrazione ed utilizzo di combustibili fossili portano ad una liberazione aggiuntiva in atmosfera di inquinanti, normalmente incamerati nel suolo terrestre.
Uno studio condotto dall’Università di Napoli (De Vivo, 2019) non solo afferma che la zootecnia mondiale non contribuisce ad accrescere le emissioni di gas serra in atmosfera ma le diminuisce! A fronte di una produzione di inquinanti di 5.700.000 Gg (gigagrammi) (n.d.r. 1 Gg = 1000 ton), comprendente sia le emissioni ruminali che quelle derivanti dalla gestione dei reflui ed anche dalle coltivazioni, 23.700.000 Gg di anidride carbonica sono stati invece sottratti dall’atmosfera.
Gli stessi autori hanno anche declinato lo studio a livello nazionale, ed anche in questo caso il bilancio tra le quantità di CO2 equivalenti prodotte dal bestiame e quelle fissate nei foraggi ed alimenti zootecnici totali è nettamente (+32%) a favore di questi ultimi(De Vivo et al., 2020). Il bilancio del comparto quindi non solo sarebbe perfettamente neutro, ma anzi, in positivo e contribuirebbe anche a mitigare l’effetto inquinante derivante da altre fonti di emissione.